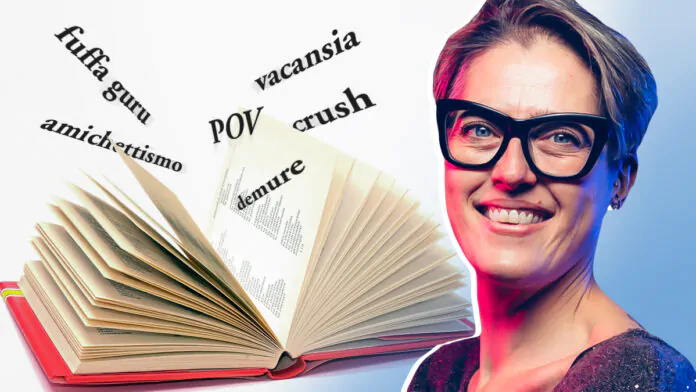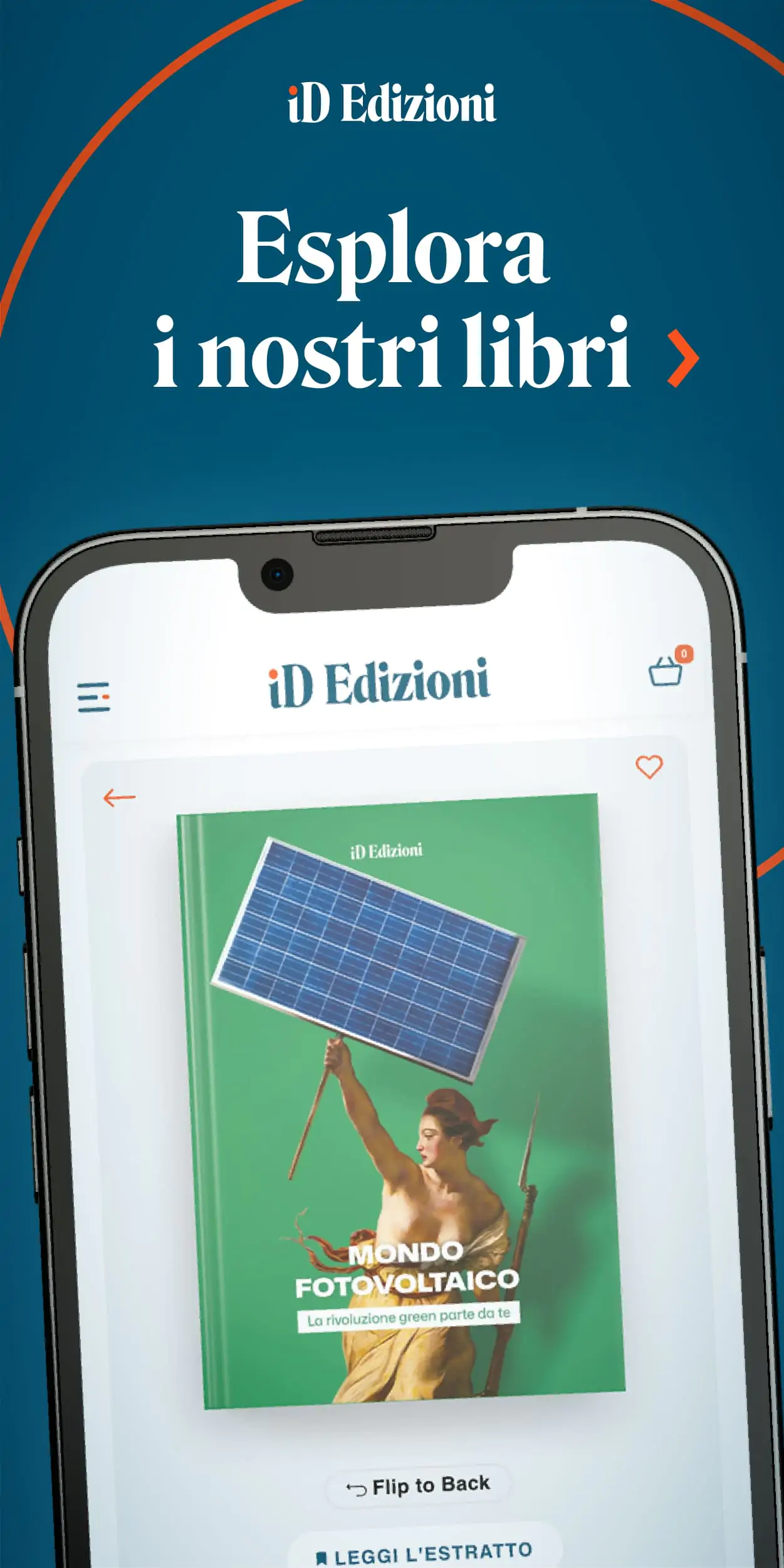La lingua che cambia secondo Vera Gheno. Quante volte nel corso del 2024 abbiamo sentito, e utilizzato, termini ‘vacansia’ in riferimento all’incapacità di godersi il meritato riposo estivo, o ‘boppone’, alzando il volume di una canzone mai ascoltata prima e molto orecchiabile in macchina o in treno?
Il Libro dell’Anno 2024 della Treccani ripercorre gli ultimi 365 giorni attraverso il mutamento della lingua italiana, la quale diventa sempre più duttile, inclusiva e aperta a un arricchimento culturale senza precedenti.
In un mondo imperversato dai conflitti in Ucraina e in Medio Oriente, dalla rielezione di Trump a presidente USA all’ascesa del ‘Re Mida’ dell’innovazione, Elon Musk, anche il linguaggio subisce delle trasformazioni profonde, si spacca e si ricompone, in parole nuove e dai molteplici significati in vari contesti.
Grazie al mondo del web e al massiccio uso e cassa di risonanza dei social non abbiamo potuto far a meno di leggere del chiacchierato ‘dissing’ tra Tony Effe e Fedez, o anche del ‘pezzotto’, dispositivo utilizzato per vedere illegalmente dei contenuti TV visibili solo a pagamento.
E ancora, quante volte su Instagram e TikTok ci è capitato di vedere video, specialmente di creators di giovane età, in cui vi era scritto ‘POV’ che, come si legge su Treccani, indica “un tipo di ripresa nel quale il creatore del contenuto non compare in scena, ma mostra in soggettiva un punto di vista specifico per favorire l’immedesimazione nella storia da parte di chi osserva il video”.
Dai neologismi agli anglicismi che fanno sempre più parte dell’uso comune, come è cambiata la lingua italiana nel 2024?
L’intervista a Vera Gheno

La redazione de ildigitale.it ha dialogato a lungo con la sociolinguista ed esperta di comunicazione digitale, Vera Gheno.
Prima di procedere in questo scambio, facciamo però una precisazione: la sezione dei neologismi è una parte del sito Treccani e si riferisce ai termini nuovi maggiormente utilizzati nella lingua italiana, ma ciò non corrisponde poi a quello che si trova sul cartaceo, come ci fa notare la stessa Vera Gheno: “Ogni volta che viene fatta una nuova edizione del vocabolario, sarà poi valutato cosa, di quei termini raccolti di anno in anno, entra davvero nel lemmario o magari no”. Addentriamoci ora tra i cambiamenti della lingua italiana.
Nel Libro dell’anno 2024 Treccani ha evidenziato alcune nuove parole che stanno entrando nell’uso comune: ‘amichettismo’, ‘fuffa guru’, ‘pezzotto’, ‘sdigiunino’. Come nascono le nuove parole e quanto incide la rete nella diffusione?
Credo che più che dalla rete di per sé siano parole legate allo “spirito del tempo”, o Zeitgeist, con una parola tedesca. Ciò che succede nella realtà ha ripercussioni sulla lingua, soprattutto sul piano lessicale, che è quello in assoluto più veloce a muoversi. E dunque, osservando le parole nuove che si sono affacciate al nostro uso nel corso dell’anno, si può intuire cosa sia successo nel nostro mondo, nella nostra società. La rete, soprattutto con i social, sicuramente contribuisce a far girare certi tormentoni con più facilità, ma non è sempre essa stessa causa o motivo della creazione di neologismi.
Treccani evidenzia l’uso massiccio di anglicismi come ‘alcolock’, ‘crush’, ‘dissing’, ‘pandoro-gate’, ‘swift economy’. La lingua italiana è sempre più contaminata dagli inglesismi? E si parla sostituzione del linguaggio, o è semplicemente un altro modo (più snello) di dire le cose?
A me non piace parlare di contaminazione, che pare una cosa brutta, disdicevole. Piuttosto, preferisco che si parli di ingresso dei forestierismi nella nostra lingua. L’italiano, per la posizione che il nostro Paese ha in mezzo al Mediterraneo, è da sempre crocevia di migrazioni, rotte commerciali, ecc. ed è ricco di parole prese da altre lingue, in forma integrale o adattata. Una volta, la lingua internazionale di cultura era il francese, che ha lasciato tante tracce in italiano.
Oggi lo è l’inglese. Indubbiamente, ci sono dei contesti in cui gli anglismi, per una serie infinita di motivi ― tra i quali l’icasticità di certi termini inglesi e la facilità con cui si creano parole in quella lingua ― sono molto presenti, forse pure troppo. Ma il vero problema, per me, non sono le parole inglesi tout court (quelle citate hanno un senso, a mio avviso), bensì la tendenza che si riscontra in determinati ambienti a usare l’inglese per darsi un tono, non per necessità espressiva o di precisione semantica.
Quando si arriva a dire una frase come “La reason why di questo ad risiede nella mission e nella vision del brand, che mettono al centro l’experience della buyer persona“, ecco, mi chiedo se sia davvero necessario. Ricordo sempre le parole di Francesco Sabatini, ex presidente dell’Accademia della Crusca e immenso linguista, che in un suo saggio scriveva di accertarsi dell’inesistenza in italiano di un termine perfettamente corrispondente a quello inglese che ci verrebbe da usare, prima di usarlo.
Secondo Treccani ‘rispetto’ è la parola del 2024. Sei d’accordo? E ti piace l’idea che ogni anno possa essere rappresentato da una parola?
A me piace sempre tanto il giochino delle “parole dell’anno”. Però, devo essere sincera, preferisco la maniera in cui viene scelta dall’Oxford Dictionary, che mette a disposizione una rosa di termini rilevanti e poi indice una votazione pubblica. “Rispetto” è una bella parola, ma è evidente che chi l’ha scelta l’ha fatto come una specie di richiamo per i mesi a venire, non perché “rispetto” sia stata davvero la parola centrale al 2024. Insomma, io di rispetto in giro ne ho visto davvero poco, nell’anno passato. Comprendo l’intento pedagogico di Treccani, ma allora, se dovessi scegliere una parola-totem da regalare, per così dire, al 2025, sceglierei “pace”: forse banale, ma quanto mai necessaria.
Da TikTok derivano neologismi come ‘creator’, ‘delulu’, ‘demure’, ‘POV’ e ‘slayare’. I social interferiranno sempre di più nei processi di evoluzione della lingua italiana?
Non credo. I social fanno i social. Sicuramente amplificano tanti fenomeni di costume, ma non la vedo come un’interferenza. Diciamo che, McLuhan alla mano, possiamo dire che ogni mezzo di comunicazione influisce sulla forma del messaggio, e che quindi i social influiscono come in passato i giornali, la radio, la televisione, ecc. Per me non è un bene né un male, è semplicemente un fatto.
Vuoi fare qualche previsione per il futuro su nuovi possibili termini?
Tutto dipende da quello che accadrà in Italia e nel mondo. Il lessico, alla fine, è la cartina al tornasole di quello che accade a noi e attorno a noi. Difficile, quindi, fare previsioni. Speriamo succedano cose più belle di quelle accadute negli ultimi anni.
Leggi anche: Cos’è il “linguaggio ampio” e perché sostituisce il “linguaggio inclusivo”: ne parliamo con Vera Gheno